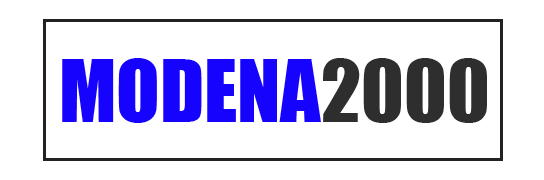Giovedì 2 dicembre 2010, al cinema Al Corso di Reggio Emilia, verrà presentato in anteprima nazionale, come ultimo appuntamento dell’edizione 2010 della Biennale del Paesaggio, “Case abbandonate”, il nuovo documentario di Alessandro Scillitani co-prodotto dalla Biennale del Paesaggio e da Fragola Film di Mirella Gazzotti.
Giovedì 2 dicembre 2010, al cinema Al Corso di Reggio Emilia, verrà presentato in anteprima nazionale, come ultimo appuntamento dell’edizione 2010 della Biennale del Paesaggio, “Case abbandonate”, il nuovo documentario di Alessandro Scillitani co-prodotto dalla Biennale del Paesaggio e da Fragola Film di Mirella Gazzotti.
La Biennale del Paesaggio è da anni particolarmente attenta alle tematiche affrontate da Scillitani in questo suo nuovo progetto di ricerca. Nel 2006, infatti, la Biennale aveva presentato a Reggio Emilia alla Cavallerizza il documentario di Gianni Celati dal titolo “Visioni di case che crollano” che documenta la campagna attorno al delta del Po costellata di casolari abbandonati, dove il paesaggio appare deserto e quasi del tutto privo di presenze umane.
La proiezione del filmato sarà preceduta da un’introduzione della presidente della Provincia di Reggio Emilia Sonia Masini. Il tema del recupero di case e borghi di pregio secondo criteri rigorosi nella tutela del segno storico-architettonico e dei contesti paesaggistici è una delle priorità nelle scelte di programmazione territoriale della Provincia reggiana, che ha già operato in modo cospicuo su questo fronte e anche in futuro, partendo da queste riflessioni culturali, verranno realizzate azioni concrete di recupero e valorizzazione del nostro patrimonio. E’ inoltre di recentissima pubblicazione il volume “Costruire il paesaggio – 10+1 istruzioni per l’uso” che la Biennale del Paesaggio ha realizzato con il polo piacentino del Politecnico di Milano, un testo di indirizzo per le buone prassi da seguire nella progettazione di nuovi edifici nel rispetto del paesaggio, scaricabile integralmente dal sito della Biennale e reperibile gratuitamente nella versione cartacea contattando la segreteria organizzativa della Biennale.
“Case abbandonate” s’inserisce, dunque, in questo filone di ricerca approfondendo alcuni aspetti che legano diverse realtà presenti dal nord al sud del nostro paese. Le case abbandonate sono tante, nascoste. La loro esistenza è accompagnata da leggende, racconti, storie da raccogliere anche attraverso le immagini, tracce abbozzate, storie che scelgono di farsi scoprire, storie nascoste che devono essere inseguite con la curiosità e l’immaginifico stupore tipico dell’infanzia, storie che si dipanano come fili di Arianna. Alessandro Scillitani, regista e Mirella Gazzotti, direttrice artistica del Teatro della Fragola, hanno intrapreso così un nuovo viaggio che, attraverso piccole tappe documentate, dà conto di un’Italia invisibile ai grandi media e al grande pubblico, che però esiste, sopravvive giorno dopo giorno, rendendo l’Italia un paese ricco di straordinarie avventure umane e custode di un patrimonio storico, culturale, artistico unico al mondo.
Il documentario è il frutto di più di un anno di ricerche compiute in giro per l’Italia, viaggiando in automobile, nave, aereo, treno, per raggiungere proprietari di case spesso sperdute nelle campagne o nelle montagne italiane, lontane dal traffico cittadino, nascoste in angoli del paese difficilmente raggiungibili. Dopo ricerche telefoniche e contatti personali, grazie alla tenacia e intraprendenza che caratterizza la Gazzotti, anche nel suo lavoro teatrale di ricerca popolare, i due attori di questo documentario partivano per nuove mete, ogni volta convinti e consapevoli dell’importanza del loro lavoro. “Luglio 2010: siamo andati a Paralup”, ci racconta il regista ”luogo di resistenza e memoria contadina. Dall’alto si vede tutta la Valle Stura, fra piccoli borghi abbandonati da anni, vasche da bagno usate come abbeveratoi e mondi ormai dimenticati. A Paralup, invece, si sta compiendo un piccolo miracolo. Il luogo dove i primi partigiani del Piemonte trovarono rifugio nell’autunno del ’43, sta ora riprendendo vita, grazie alle energie profuse dalla Fondazione Nuto Revelli. Abbiamo intervistato Marco, il figlio di Nuto, Antonella Tarpino e Luigi Schiffer, in questi luoghi simbolo di una nuova resistenza e loro ci hanno detto che il borgo sta riprendendo vita, sia come luogo principe della memoria, sia come luogo di recupero della vita contadina.”
Il documentario è il frutto di un lavoro preciso, attento, che da un lato vuole cogliere l’essenza e le caratteristiche dei luoghi, dei paesaggi, dall’altro vuole rendere testimonianza della loro memoria antropologica, nella consapevolezza che la memoria dei luoghi è anche la memoria dell’uomo. Ecco allora le interviste e le testimonianze dirette raccolte dalla voce di chi quei luoghi li ha abitati, conosciuti, praticati. Ma non solo. Il documentario raccoglie infatti anche numerosi e importantissimi contributi di scrittori, registi, poeti, storici, come Tonino Guerra, Pupi Avati, Marco Revelli, Antonella Tarpino, Vito Teti che raccontano le loro storie, le loro esperienze di vita vissuta, le loro case e la loro memoria di case abitate e abbandonate. “Ogni volta che trovo un borgo abbandonato” dice Tonino Guerra “ci vado molto volentieri, perché mi sembra di farlo rivivere, e di ritrovare tutti gli abitanti che c’erano. E’ un’impressione di tenerezza che ho verso questo mondo abbandonato.”
Villa Boccaccini, una villa Liberty nei lidi di Comacchio, è stata set cinematografico proprio per Pupi Avati. Il regista spesso è stato ispirato da luoghi abbandonati, addirittura il film “Le strelle nel fosso” è nato tutto intorno a una casa abbandonata, che gli ha ispirato la storia. Villa Boccaccini è per certi versi la protagonista del celebre film “La casa delle finestre che ridono”. “Siamo andati ad intervistare Pupi Avati” racconta Scillitani “e poi abbiamo anche intervistato gli eredi di quella villa, ora ridotta a macerie.”
Il progetto comincia dal mistero, da ciò che rende affascinanti i luoghi perduti, dalle incursioni notturne per goliardia o per sfida, per poi addentrarsi fisicamente nelle case e nei borghi non più abitati, alla ricerca delle motivazioni che ne hanno causato il declino. Si raccontano leggende, storie fantastiche che, partendo da fatti realmente accaduti, tendono a riempire di magia l’abbandono di un paese.
“Rontano, nella provincia reggiana” racconta Scillitani “ha origini antichissime di proprietà dei duchi d’Este. Storicamente era una riserva di caccia. Nei primi del ‘900 divenne di proprietà della famiglia Maestri, che aveva la concessione di tutte le pompe di benzina di Bologna. Arrivavano con la macchinona in territori abitati da contadini. I cacciatori erano tutti nobili e personaggi illustri, si parla di D’Annunzio, Eleonora Duse, Coppi e Bartali. Per il territorio reggiano si trattava di una cosa stranissima. Era un borgo a tutti gli effetti, ci abitavano un centinaio di persone, c’era la chiesa, la scuola. Poi, con la morte dei due fratelli, uno dei quali morto suicida per debiti, tutto andò in rovina. Prima fu tentata una sorta di autogestione da parte di un guardiacaccia, poi dagli anni ’70 venne abbandonato, e da allora è diventato meta di curiosi, territorio per la paura e il mistero, si parla addirittura di messe sataniche nella chiesa abbandonata. Ora una parte di questo vasto territorio è stata recuperata da una cooperativa, che ha realizzato un agriturismo”. E continua “… ad Aguscello, nel ferrarese, c’è un lugubre edificio abbandonato, proprio nel centro del paese. Si vocifera che lì siano stati fatti esperimenti sui bambini, e che ci tenessero i malati di mente, che addirittura in tempi bellici i nazisti ci torturassero i bambini. Queste leggende sono alimentate dalle macchie sulle pareti, che qualcuno identifica con le ombre dei bambini morti tragicamente. In realtà si tratta di un edificio dismesso in seguito alla riforma degli istituti psichiatrici e della legge Basaglia”.
E poi si attraversa l’Italia, tra spopolamenti dovuti all’industrializzazione, terremoti e degrado. Reneuzzi, Toiano, Valle Re, Craco, l’Aquila sono solo alcuni dei luoghi analizzati.
Reneuzzi è un borgo in provincia di Alessandria, abbandonato dagli anni ’60, a causa dello spopolamento delle valli e dell’industrializzazione che ha portato all’abbandono delle valli e delle campagne, verso le città. C’è però un fatto di sangue. Nei piccoli paesi, normalmente, i cognomi sono tutti uguali. Due cugini, un amore non corrisposto, lui ha ucciso lei, e si dice che quel terribile omicidio sia la causa dell’abbandono del paese.
Il documentario mette in luce l’immenso patrimonio che viene perduto quotidianamente nell’indifferenza, in contrapposizione alla smania di costruire nuovi quartieri nelle periferie delle città. Si evidenza la contraddizione di un paese che cerca le vallate e la campagna come luogo di pace e di vacanza, rifiutandolo come concetto di vita quotidiana. Si costruiscono outlet a immagine e somiglianza di paesi abbandonati, senza però averne l’anima e la struttura.
Infine, vengono presi in esame alcuni luoghi, recuperati all’oblio attraverso la tenacia di alcuni. E’ il caso di Alice Superiore, in provincia di Torino, che in controtendenza rispetto a paesi della medesima tipologia vive un ripopolamento da parte delle nuove generazioni; oppure le cascine milanesi, recuperate attraverso un modello ecocompatibile, o ancora l’esperienza friulana degli alberghi diffusi, ormai esportata in tutta Italia e anche altrove.
 Il nostro paese è caratterizzato da un’attitudine a dimenticare, a trascurare il valore della memoria, questo lavoro vuole dunque dedicarsi alla documentazione di ciò che va sgretolandosi giorno dopo giorno.
Il nostro paese è caratterizzato da un’attitudine a dimenticare, a trascurare il valore della memoria, questo lavoro vuole dunque dedicarsi alla documentazione di ciò che va sgretolandosi giorno dopo giorno.
L’ingresso è gratuito, dato il limitato numero dei posti si consiglia la prenotazione telefonica (Segreteria organizzativa della Biennale tel. 0522/444421) oppure via mail (info@biennaledelpaesaggio.it).